Di Noemi Iacoponi
Il protagonista di Roma senza papa, primo romanzo edito di Guido Morselli scritto nel 1966 (ma pubblicato soltanto l’anno seguente al suo suicidio), è don Walter. Vive ed è sacerdote in Svizzera, ma il libro è il resoconto del suo viaggio a Roma, città in cui si è formato trent’anni prima e da dove, in un futuro imprecisato vicino all’avvento del 2000, è scappato anche il papa. Don Walter, che aveva lasciato Roma nel 1972, sente il richiamo di quella città: “un panorama di tetti fatiscenti, lontani capitelli di vecchie colonne. E lo sciacquone che non funziona. Roma.” Una Roma che riconosce “dal dialetto grosso, estraneo all’asciutto italiano che senti parlare a Arezzo o a La Spezia; [….] con nuvole ovviamente barocche che ‘nun ce la fanno’ a strigarsi dai pinnacoli di Sant’Agnese.”
Le virgolette sono chiuse dopo “nun ce la fanno”, eppure “strigarsi” è la forma abbassata del più comune verbo “districarsi”. Questo è l’indiretto libero che Pierpaolo Pasolini sperimenta nel suo primo romanzo romano, dei “pischellini” e del Riccetto “che in mezzo al fiume alzava una moina che non finiva mai. […] Andava sotto con la capoccia tirando su il sedere e le cianche come una papera, faceva il morto a galla con la pancia in fuori cantando a tutta callara.”
Quei “ragazzi di vita” di Pasolini, nella Roma di Morselli sono “regazzini” che giocano all’oratorio mentre le donne li stanno a guardare. “Ogni tanto una di esse raggiunge uno dei piccoli giocanti e vocianti, gli rialza le mutande, gli asciuga il naso. Regazzini, o piuttosto ‘ste criature’.”
Evidenti sono le incursioni di termini propri del linguaggio romanesco, e non dell’italiano alto in cui, invece, è narrato l’intero romanzo. Assistiamo a quel discorso che ha ben chiaro Pasolini nel suo Intervento sull’indiretto libero, in cui dice che “la contaminazione non avveniva tra la lingua bassa e la lingua media, ma tra la lingua bassa e la lingua alta.” In Morselli non c’è medietà linguistica, ma contemporaneamente uno stesso movimento di approfondimento su entrambi i fronti: nel basso della lingua dialettale, come nei preziosismi della linea alta. Si vedrà più avanti che la lingua di Morselli andrà anche oltre quest’espressività composita dell’italiano, di cui appunto parla Pasolini, e che in generale lo stile e la lingua sono dispositivi fondamentali per comprendere il valore dell’opera morselliana. Per avere meglio idea dell’oscillazione che compie l’italiano di Morselli nel romanzo, si rimanda all’estratto seguente, sempre radicato nella lingua locale di Roma, che lo avvicina a Pasolini stesso.
In soccorso dei tre uomini plana dal cielo un micro-cottero della Questura. Angelo ex machina, la poliziotta apostrofa le molestatrici (“mignottelle” è il termine romano), che però non mollano la presa; si voltano inviperite. “Aoh, stracotta!”. La scena, di una comica violenza, gronda colore (e rumore) locale. A complicarla ecco i ragazzini immancabili. Cinque, sei, s’infilano nel còttero, manovrano le leve, accennano a decollare. Mi aspetto che la poliziotta passi a scapaccionarli. Macchè. “Ve fate male, bambini”, e si limita a agguantare la maniglia del veicolo per trattenerlo, sempre redarguendo le mignottelle. […] “Urbs inenarrabilis” commentava Giovenale.
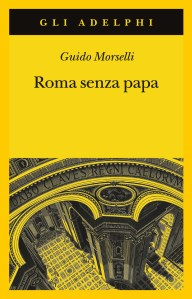
Il passo in questione permette alcune importanti considerazioni, soprattutto se accostiamo Roma senza papa a Ragazzi di vita e, più in generale, alle teorie di Pasolini sulla lingua. Primo dato, fra gli altri, da sottolineare, è il sintagma “gronda colore (e rumore) locale”, pienamente pasoliniano. Nell’introdurre un volume di poesie dialettali, Pier Paolo Pasolini si riferisce al dialetto definendolo “punta espressiva della vivacità orale”; e per descrivere l’indiretto libero pasoliniano il critico Walter Siti utilizza la formula “tinta in più per la propria tavolozza stilistica”. In questo senso i due termini “colore” e “rumore”, utilizzati nel testo da Morselli, fanno sistema con l’orizzonte linguistico di Pier Paolo Pasolini.
Se, però, ad un primo impatto l’indiretto libero di Guido Morselli sembra soltanto ricalcare la necessità di cogliere le vibrazioni della lingua, propria del Pasolini di Ragazzi di vita; una lettura più approfondita rende problematico il significato dell’utilizzo di quel dispositivo stilistico, secondo termini usati, sul piano teorico, dallo stesso Pasolini. Nel già citato saggio Intervento sull’indiretto libero, infatti, l’autore inizialmente riporta la più tradizionale accezione di indiretto libero. Lo presenta come uno strumento di cui lo scrittore ha bisogno per “rivivere grammaticalmente” un discorso, sintomo di una simpatia nei confronti del personaggio parlante, che si estende all’intero mondo di cui è rappresentante. Più avanti, però, aggiunge:
A contraddire l’idea della “simpatia”, c’è anche un’altra delle “condizioni stilistiche” necessarie a far scattare l’apparato grammaticale del discorso libero indiretto: ossia l’ironia. […] Ma ironia in senso specifico, corrente: ossia la “mimesis caricaturale” che consiste nel “rifare il verso” al parlante. […] Bisogna insomma includere nei sentimenti che creano le condizioni stilistiche dell’oratio obliqua, anche un sentimento di antipatia.
Mentre la posizione di Pasolini in Ragazzi di vita è chiaramente di osmosi simpatetica con la lingua di quel mondo che l’autore vuole rivivere, lasciandosi contaminare, per poterlo meglio descrivere e raccontare; in Morselli non si ha altrettanta chiarezza. Da una parte il personaggio di don Walter sembra prendere le distanze dal mondo romano, di cui critica i malfunzionamenti e le ingenuità. Dall’altra, però, nel libro pare essere proprio quello dell’arretratezza l’unico spazio per conservare una solidità morale, religiosa, scientifica; al contrario della tendenza al progresso che distrae, confonde e parla una lingua sempre più tecnica e contaminata. Quello che invece si può dire con certezza è che in Roma senza papa, e in generale nella produzione di Morselli, si trova quella che per Pier Paolo Pasolini è l’implicazione e la conseguenza dell’applicazione, in un testo, del libero indiretto: “una coscienza sociologica, chiara o no, dell’autore”.

È un romanzo, Roma senza papa, in cui la lingua, anzi le lingue, sono portatrici di una decisa critica dell’autore stesso. Non è un caso che, per evocare la decadenza della chiesa, fra le innumerevoli mancanze che si potrebbero trovare ad un papa magari sul piano spirituale o religioso, Morselli denunci invece la poca dimestichezza con la lingua italiana. Il linguaggio e le scelte linguistiche hanno un deciso valore semantico e sono il mezzo attraverso cui l’autore esprime la propria posizione ideologica. “Giovanni è il secondo straniero a salire sul Soglio ai tempi nostri. Il primo papa eletto che non sapesse una parola d’italiano. Lo ha appreso dopo, e lo pronuncia ancora a stento”. L’autore non si nasconde, e mette in chiaro nelle parti narrative del testo, attraverso il resoconto di don Walter, l’attenzione linguistica che caratterizza l’intera opera e a cui sono affidate riflessioni interpretative e critiche. Ancora per approfondire questo aspetto e definire ciò che spinge Morselli ad usare l’indiretto libero, si pensi ad un ulteriore esempio. La moglie di don Walter, in questo futuro approssimato in cui anche i preti cattolici possono sposarsi, scrive al marito, lontano da casa: “sei nella città che ha dato al mondo la parola ‘sesso’ (sexus, da secare). Guàrdati da questa città corrotta e corruttrice, sii puro”. Lotte, la donna, che è rimasta in Svizzera e non ha mai conosciuto Roma, attenziona il marito affinché non si contamini con essa, proprio avvalendosi di una parola per definirne l’anima.
Poco più avanti, però, in quello che nella finzione morselliana è un vero diario di don Walter, compare una nota a piè di pagina (l’unica), scritta dal sacerdote: “dovrò ricordarmi di dare in appendice, o in fondo ai pezzi da mandare al giornale, la traduzione degli incisi italo-romaneschi di cui sto infiorando la mia prosa”. Utilizza il verbo “infiorare”, come a dire che quella parola romanesca, quella lingua superstite di una Roma ormai allo sfacelo, è ciò che lo impreziosisce, abbellisce, adorna. E si propone soltanto di fare un’operazione che, invece, Pier Paolo Pasolini realmente realizza in appendice a Ragazzi di vita. Un glossario “più per scrupolo, e curiosità, che per effettiva utilità”, ma che a tutti gli effetti contiene la versione in italiano standard dei termini romaneschi presenti nel romanzo.
Rifacendosi all’alternativa simpatia/antipatia che, secondo Pier Paolo Pasolini, è alla base dell’utilizzo in un testo dell’indiretto libero, pare di poter trarre la seguente conclusione. Guido Morselli, autore del proprio romanzo, utilizza l’indiretto libero spinto da una fascinazione simpatetica nei confronti di quel parlato incontaminato, ultimo vassallo di una società ormai sconfitta da quella moderna che, l’autore stesso, critica e disarticola nell’intera opera. Don Walter – autore anch’egli, del diario – è parte della società problematizzata da Morselli e straniero che guarda con scetticismo l’ambiente romano: per questo l’indiretto libero, integrato nel suo diario, dà, al contrario, l’idea di “mettere in luce dal di dentro gli elementi odiosi e asociali” della Roma cui assiste.
Sempre citando Pasolini, don Walter sembra “fare il verso” al popolo romano, pur conservando uno sguardo analitico e distaccato che non prende una posizione nei dibattiti ideologici inseriti da Morselli nel romanzo. Notiamo un “certo umorismo in queste sentenze ‘pseudo-obiettive’, che accettiamo soltanto con certi dubbi come opinioni al livello dell’autore”, per dirla con Spitzer.
Don Walter, infatti, definisce così gli abitanti di Roma: “un popolo che non si eccita, non reagisce, ha un fondo di cinismo, è scettico, è scanzonato, si accontenta di vivere come può, per loro la Storia non è che contingenza, precarietà, passaggio”. Oppure riferendosi ad un dialogo con una certa Suor Pasqualina, in tono chiaramente ironico (a mo’ di Gadda come diceva lo stesso Pasolini), scrive: “mi ha rivolto parola in tedesco contaminato di patois locale”.
Siamo, però, nello stesso libro in cui per definire gli inserti romaneschi si usa un verbo dall’area semantica dell’abbellire, dell’adornare, del decorare; in cui il dialetto vivace dei ragazzini romani viene definito “colore”. Ecco che, rischiando un azzardo, nel romanzo di Morselli piuttosto che l’indiretto libero teorizzato da Pasolini in merito alla letteratura, mosso o da una volontà di immedesimarsi in una coralità di parlanti, o dal desiderio di prenderne le distanze, pare di poter vedere la soggettiva libera indiretta del cinema. Avviando la propria riflessione dal discorso libero indiretto della scrittura, Pier Paolo Pasolini riflette su un “cinema di poesia” che, trasferendo nel linguaggio cinematografico quel dispositivo stilistico, si avvalga dell’inquadratura della soggettiva libera indiretta.
La prima caratteristica di questi segni costituenti una tradizione del cinema di poesia, consiste in quel fenomeno che normalmente e banalmente vien definito dagli addetti ai lavori con la frase: “far sentire la macchina”.
Questo monito a far riconoscere allo spettatore al cinema la presenza di un soggetto che impugna la macchina da presa ed effettua una ripresa in soggettiva, sembra rispecchiare la traccia del Guido Morselli autore, fra le pagine del diario di don Walter, quando avviene quello sfasamento nel modo di intendere e considerare l’applicazione del discorso libero indiretto.
L’intellettuale mimetico in genere, dunque, poteva un tempo rinunciare alla propria lingua e rivivere il discorso di un altro a patto che quest’altro fosse contemporaneo o meglio, molto meglio, preistorico rispetto al lui […]: ma ora non può, per un’angoscia che si fa sopportabile solo se apolicatticamente ironica come nella pop art, adottare i modi linguistici di chi è più avanti di lui nella storia.
Proseguendo nel suo ragionamento in merito al libero indiretto, Pier Paolo Pasolini esprime il proprio disincanto, a più riprese lamentato negli articoli di carattere sociopolitico, anche sul piano della letteratura. Una lingua ormai borghese non è più in grado di vestire i panni dell’altro e farsi libero indiretto, secondo Pasolini: la decadenza di una lingua mimetica e l’artificiosità di una sua qualunque sostituta, rendono necessaria la ricerca di una terza lingua, che chiama “X”. Lo prefigura come un linguaggio che colga l’evoluzione della lingua del passato in quella del futuro, e la fotografi nel suo movimento sfuggevole: quella che per Pasolini resta una “operazione astratta”, in Morselli forse si fa tangibile.
Sicuramente il genere letterario e l’idea di romanzo che anima Morselli contribuiscono a rendere concreto l’utilizzo, se pur polemico ed ironico, di una lingua del futuro. La sua narrativa, infatti, si basa su una realtà storica però irreale, in cui i dati si presentano come fantasmi di un’ipotesi, nel caso di Roma senza papa futuristica. Con le parole di Francesca Parmeggiani: “la narrazione che ha come oggetto il tempo è il luogo privilegiato, in quanto esterno ai fatti pur riproducendone i rigorosi meccanismi di accadimento, da cui osservare e criticare la società contemporanea”. Così Morselli opera all’interno dei suoi romanzi, e questo sguardo distorto e prospettivistico sul tempo lo rende anticipatore e previsore anche della lingua di quel futuro ipotizzato combinando memoria e fantasia. Come osserva il critico Laroche, infatti, Morselli non si dedica all’utopia, ovvero all’immaginazione di un mondo ideale, né alla distopia, e quindi alla versione apocalittica del futuro: piuttosto compie un processo di anticipazione, descrivendo il mondo per quel che sarebbe se proseguisse nelle direzioni del presente. L’approccio di Morselli nei confronti della storia si riflette e rispecchia sul versante della lingua.
– Cerchi “Time”, Padre, ne vale la pena. La nostra Presidente dice che Giovanni “le piace”. She’s fond of him, mi capisce? Le piace a quanto pare un po’ troppo. È attratta, ma attratta dalle sue qualità di uomo. I suoi occhi, la sua voce, eccetera. Questa è sincerità americana, e la Curia qui, non è disposta a apprezzarla. A torto, secondo me.
Durante un discorso diretto, registrato nel diario di don Walter, il parlante inserisce una frase in indiretto libero, ed è in inglese. Questa è la prospettiva futuristica della lingua che Morselli riesce a rendere concreta nel suo romanzo, e che testimonia una preoccupazione per le stesse questioni linguistiche che interessavano Pier Paolo Pasolini.
La spinta verso l’inglese, e in generale l’analisi di un rapporto problematico con l’America, sono a tema in un altro romanzo di Morselli, scritto l’anno prima di Roma senza papa, intitolato Il comunista. Il protagonista è un membro del PCI e i vertici geografici della vicenda sono: l’Emilia, da cui proviene; poi ancora una volta Roma, dove raggiunge posizioni di rilievo nel Partito e l’America. Inizialmente l’America è il luogo innominabile della sua gioventù, che contiene i ricordi di una vita precedente, in cui Ferranini ha ceduto alla tentazione dell’omologazione borghese. Assunto in una grande azienda ha sposato la figlia del dirigente, Nancy, e si è dimenticato delle teorie marxiste cui, invece, avrebbe voluto votare la propria vita. Il Partito Comunista, il marxismo, l’ostilità per la borghesia e l’attenzione ai lavoratori del proletariato sono temi che collegano, ancora una volta, Morselli a Pasolini. Si può dire ancora di più: la resa ideologica del protagonista de Il comunista ha molto a che fare con le consapevolezze di Pasolini dalla metà degli anni Sessanta, davanti alle quali, però, a differenza di Ferranini non si è assopito né ha spento la propria forza vitale.
A levargli l’entusiasmo – al comunista di Morselli – non era stato paura di violenze poliziesche o dispetto di vedersi squagliare gli uditori. Peggio. Altri interessi s’insinuavano in lui, sintomi di un processo regressivo in atto, l’ambiente che se lo assimilava così, e nel senso più preciso, estraniandolo a lui stesso. La potenza di peristalsi che caratterizza la società borghese.
Quando, alla fine del romanzo, Ferranini è costretto a tornare in America per un problema di salute di Nancy, da cui è separato da molti anni, la lingua è di nuovo il mezzo con cui descrivere la condizione psicologica ed ideologica del personaggio. Si legge:
Intanto pensava [Ferranini], e già gli capitava, a frasi, di pensare nella lingua straniera: Nancy’s changed, too bad I’m changed too. Ma poi, chi lo sa, sono cambiato o dipende che non ho più salute?
Ancora l’indiretto libero che contiene l’inglese, e Morselli ne fa uso per esprimere la confusione del protagonista con il mondo americano da cui vorrebbe sentirsi esente, ma verso il quale continua a sentire una tensione inspiegabile, figlia della “potenza di peristalsi” del capitalismo.
Tornando a Pasolini, nella seconda parte dell’Intervento sull’indiretto libero l’autore parla del latino, mettendolo in relazione antitetica con la lingua tecnologica. Morselli, in Roma senza papa, esprime chiaramente e con sottilissima ironia questo contrasto, fondendo nel proprio linguaggio il latino della Chiesa e l’inglese del mito progressista.
Un polo – scrive Pasolini – è, appunto, la negazione, e l’altro è il mito del futuro: le loro cose scritte si presentano come non-storiche, e, insieme, come prefiguratrici di una immediata storia futura. Nella fattispecie linguistica, se non ci inganniamo, la negazione è negazione dell’osmosi col latino, e il mito è il mito dell’osmosi tecnologica. L’uomo insomma viene intero nella sua prefigurazione di “homo technologicus”.
E se apriamo il libro di Morselli si trovano passi di questo genere:
Il pluralismo è, in tutto il resto, un brainwashing di penetrante capillarità, i suoi risultati sono puntuali e vistosi. I discorsi degli studenti, e spesso anche i saggi scritti e le dissertationes, se ne permeano. Ciò che è peggio, se ne permeano il costume e l’intendimento. La ‘mens’ individuale, nel profondo.
O ancora, “‘Vivimur et movetur’ all’ombra del gioco del calcio” e qualche riga più sotto: “mi pare di vederlo, e non lo invidio, in shorts, rincorrere sulla spiaggia onde e ondine, e un pallone di gomma a spicchi”. Il latino e l’inglese si scambiano la palla in un tennis che fotografa l’evoluzione linguistica, e quindi sociale, dell’Italia degli anni Sessanta, vista attraverso il filtro del mondo ecclesiastico. Nella mensa gregoriana a Roma, quindi, si trovano “self-service, sfondo di musiche elettroniche dell’Abate Le-Jeune. Centinaia di commensali, liste in una decina di lingue, non una bottiglia di vino, softdrinks”. E per riferirsi ai colleghi sacerdoti che si sono aperti alle teorie americane sull’apostolato, don Walter scrive “i miei amici, passati dal latte all’ice-cream”.
Le incursioni di termini inglesi, in quello che forse è il più marcato indiretto libero di Roma senza papa, fungono da spia di un cambiamento davanti al quale, questa volta in un gioco al rovescio, lo scrittore Morselli è totalmente critico ed ostile, mentre don Walter curioso. È ancora una volta attraverso le parole che Guido Morselli si fa portavoce, problematizzandola, della propria idea sul mondo. Sono i segni del cambiamento e la sintesi di idee politiche e sociali davanti alle quali l’intellettuale si interroga con coscienza.
Emblematica, a tal proposito, la seguente proposizione: “Monsignore non è testa da afferrare queste mie ‘astruserie’. (Wirrwarr, dice lui, in dialetto).” Il termine olandese in corsivo viene definito dialettale: è riportato nel testo rispettando il bisogno di autenticità e la volontà di rivivere la lingua di una coralità, che avevano spinto Pier Paolo Pasolini a registrare il romanesco dei Ragazzi di vita. È inteso come termine gergale in quanto si tratta del parlato del personaggio, che lo scrittore vuole assumere nel proprio testo. Che si dica “dialetto” anche perché si tratta di una regressione dall’italiano che, contaminandolo, ci si illude di rendere progredito?
In ogni caso sembra essere riflesso, nel romanzo di Morselli, quello su cui riflette Pasolini nel saggio Nuove questioni linguistiche. Ovvero l’omologazione dei linguaggi, non più specializzati dall’osmosi col latino, ma standardizzati tutti allo stesso livello perché influenzati da una nuova lingua della tecnica.
Ora alla guida della lingua non sarà più la letteratura, ma la tecnica. E quindi il fine della lingua rientrerà nel ciclo produzione-consumo, imprimendo all’italiano quella spinta rivoluzionaria che sarà appunto il prevalere del fine comunicativo su quello espressivo.
A questo discorso di Pasolini pare rispondere una riflessione di don Walter, e quindi di Morselli, che utilizza, nella finzione del romanzo, il ristretto campo della Chiesa per leggere una questione che invece riguarda la società e la politica italiane. In senso provocatorio e profondamente critico, infatti, nel testo si legge:
La B.B.C. diffonde la voce che il prossimo papa si chiamerà Adriano e sarà il secondo papa britannico. L’inglese, lingua veramente universale, sostituirà il latino come lingua ufficiale del cattolicesimo.
L’espressività linguistica, resa colorita da plurilinguismi di ogni genere (dialetti italiani, inglese, tedesco, latino), serve a Morselli per esprimere, pur criptato, il proprio parere sulla modernità. Il futuro della chiesa cattolica è ovviamente soltanto un pretesto in cui scongiurare che “il negro basket-man Father Johnson” diventi il papa ideale; mentre la vera analisi della realtà è diffusa su tutti i campi più urgenti a quell’altezza storica.
In conclusione, Pier Paolo Pasolini e Guido Morselli sembrano avere in comune lo scetticismo dell’intellettuale che guarda al progresso della propria realtà (anche tecnologico) ravvisandone, piuttosto, una triste recessione. Morselli sarebbe stato probabilmente d’accordo, se l’avesse letta, con la perentoria frase conclusiva del celebre articolo di Pasolini, del 1975: “io, ancorché multinazionale, darei l’intera Montedison per una lucciola”.
Per essere difensori di un’idea differente di società e politica, entrambi affidano alla lingua, al linguaggio e ai suoi strumenti, il compito di esprimere una chiara critica e lanciare un forte messaggio civile. Entrambi trovano nell’ “erfahrung” – direbbe Benjamin – il mezzo con cui rappresentare dall’interno, sia per esaltarle che per demolirle, le idee e le tendenze cui assistono, affascinati (se pensiamo al Pasolini di Ragazzi di vita) o amareggiati (Morselli, come Pasolini dalla metà degli anni ‘60). Ne deriva una prosa in rapporto problematico con la realtà, contaminata da uno o più gerghi, ognuno inserito nel testo con una chiara valenza semantica, ideologica e politica. Un tentativo di fare resistenza con le parole, comunicare chiare prese di posizione ed aggredire, valorizzando il linguaggio, la realtà circostante.
Noemi Iacoponi è nata nella provincia marchigiana. Si è laureata in Italianistica all’Università di Pisa e studia Editoria a Bologna. Ha scritto articoli culturali e racconti per alcune riviste come Limina, Rivista Stanca, Scomodo e il Tascabile.
In copertina: artwork by Bernardo Bellotto

