Di Giulia Bocchio
che se il principio è buono il resto è buono, dicevano le
vecchie nella veglia e nel sonno
D’altra parte il bando del Premio Nazionale di narrativa Neo Edizioni Anno zero era stato dettagliatamente chiaro: la ricerca avrebbe puntato su storie ibride, difficili da incasellare in un genere specifico, lontane dall’autocompiacimento e inimmaginabili. A emergere (e vincere) è stato il romanzo di Riccardo Ielmini, Spettri Diavoli Cristi Noi.
Cupo, tentacolare, a tratti onirico, ma anche orrifico in quella maniera non del tutto lacerante, eppure ambigua, che ricorda certe atmosfere alla Stephen King (penso soprattutto a It), indefinibile di per sé e tuttavia legato a riferimenti letterari sottili e cinematografici (e qui penso a Stand by me, a Twin Peaks ma anche alla serie Dark, alla neve come metafora in Kill Bill Volume 1), mai troppo invadenti, tratteggiato da una scrittura che viene dal sottosuolo vischioso di un immaginario che ha a che fare col male che la gente incarna semplicemente esistendo o che certi luoghi, così sospesi, sembrano emanare.
Terre, periferie e province ubicate lì per non accogliere altro che la disperazione e l’inettitudine, sempre però abbellita da vialetti curati e candide tendine dalle quali sbirciare il baratro là fuori.
E là fuori c’è la Contea di tolkieniana memoria, con tante spaccature e strade che si biforcano nei boschi sino ad arrivare alla frontiera, al confine al di là del quale l’erba è più verde e il tempo meglio evoluto, mappa fatta apposta per condurre i diavoli, gli spettri, i cristi e noi sempre lì, al punto di partenza, nell’eterno ritorno che fa del cervello l’organo più reattivo agli stimoli e ai traumi.

Dai qui i necessari plurali del titolo, che potrebbero essere anche letti al contrario per tentare di ricostruire a ritroso il passaggio nel labirinto della memoria, perché la voce narrante è prima di tutto un Noi che, come ogni noi degno di nota, si realizza ed esiste in virtù dei legami che lo definiscono e lo mettono in relazione con il suolo che calpesta, con la fossa che accoglie il passaggio di tutti, prima o poi. Quel corale Noi è la Confraternita – Dambro, la magnifica Frida, Bardo, Accio, Fredy, – tutti ragazzini in divenire che solcano i morenti anni Ottanta in BMX e che, in una notte senza sonno, più nera e fredda del fondo di una cantina, vedono qualcosa di simile a ciò che oggi potremmo ricondurre agli omicidi perpetrati qualche decennio fa dalle Bestie di Satana.
Rituali esoterici, una messa nera, abusi su minori, il coinvolgimento di personalità note all’interno della comunità-Contea: inizia così il romanzo di Ielmini e per come siamo abituati, o meglio, per come ci ha abituati quella alleanza fatta di coerenza tecnica fra fabula e intreccio, che sembra essere indispensabile per la buona riuscita di una storia, ecco, data questa impostazione perenne, ci si aspetterebbe di leggere da qui in poi un thriller, un giallo molto complicato, un’indagine magnetica, un percorso di formazione, e invece no grazie al cielo: niente di tutto questo.
Il fatto cardine con il quale tutto comincia resta latente, spettrale, una storiaccia che inquina i sogni e getta un’ombra invalicabile sui capitoli successivi, ma che lì (almeno fino a un certo punto) rimane; e così tutto assume un’aria sospesa, un labirinto che diventa sempre più onirico.
È questa la forza dello stile narrativo di Ielmini, è questo che l’autore si concede: dilatare tutto, per condurci al centro dell’altrove e lì lasciarci.
Siamo sempre dentro la Contea, luogo che sopravvive alle generazioni e al cambiamento climatico, terra che allatta il Diavolo, che istruisce la sapienza ancestrale delle anziane, che parlano con più rigore della Pizia di Dürrenmatt, anche se quel rigore diventa profezia mista a scaramanzia, Contea materna e delittuosa, Contea generosa che non traccia confine fra ciò che vive e ciò che muore. Limbo grottesco e labile nel quale la scrittura si fa lingua beffarda ecco perché, procedendo nella narrazione, i fatti stessi autogenerano coincidenze e connessioni sconcertanti, incontri con personaggi che sembrano appartenere alle carte dei Tarocchi, altri provenire direttamente da una transumanza umana partita da Masserie di Cristo come un romanzo fondamentale degli ultimi anni ci ha insegnato, I vivi e i morti di Andrea Gentile, perché il male, la morte e l’alito del caos non sono una triade schizzinosa, attecchiscono ovunque e caratterizzano anche due opposti come la Genesi e l’Apocalisse.
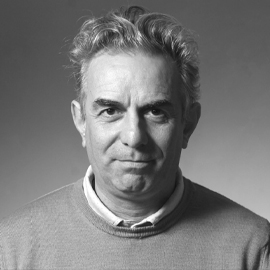
Il romanzo si regge sulle storie di vita degli strani individui che orbitano intorno alla Confraternita, esseri umani incrinati dalle circostanze, dalle vicissitudini storiche e sociali del luogo stesso perché la Contea è come un’entità, un buco nero nel Nord Italia, e non c’è contratto sociale che tenga se il degrado diventa una malìa violenta, grottesca e disperata che si insinua soprattutto nel silenzio di una comunità che sottovoce tutto giudica e tutto osserva: si piange per la morte antica e brutale di una bambina, un dolore collettivo che trasforma il padre di lei nell’Uomo Dei Boschi, un essere che vive ai confini e dunque confinato nella sua afflizione che lo tramuta in un personaggio leggendario e atavico, commovente e osceno come solo la disperazione più profonda sa imprimere a un Dna che muta: uomo che non sente più il freddo, che vaga con il membro molle di fuori e che potrebbe parlare la lingua di Belzebù se solo la vita avesse più fantasia.
Sono varie le figure drammatiche che rimangono impresse nella memoria per il loro potere evocativo e tragico, come Artù il muto, tossicodipendente senza speranza, la pornostar Stella Foxy e i suoi genitori, anche loro senza speranza, sopraffatti dalla vergogna, incapaci di accettare che quella che una volta era la loro bambina sia diventata un puro oggetto del desiderio, un’immagine fantasma utile a esplorare le potenzialità della fantasia applicata alla masturbazione, e poi ancora la famiglia di Arben Culaj resa immortale da una partita a bowling la cui descrizione è un affresco antropologico brutalmente perfetto.
Ma ci sono almeno tre capitoli che vivono di vita propria, che potrebbero uscire dal romanzo e condurre un’esistenza letteraria indipendente perché principalmente sono racconti che, pur nella coerenza compositiva dell’opera generale, si prendono una libertà che fa bene prima di tutto a chi legge; di questi tre ne citerò uno solo, quello che ci riporta a un altro romanzo ancora, 2666 di Roberto Bolaño. Le 2666 righe di Frau Ingeborg Bauer è un capitolo che non passa inosservato, personalmente avrei voluto non finisse mai, ma finisce, come ogni altra cosa, e l’immagine di un certo Balana-Belana o Bolaño – perché non sempre è possibile ricordare con precisione le cose quando il vero non coincide con il reale – potrebbe sembrare un puro esercizio o un artificio non richiesto, eppure funziona, è parte integrante di quel senso di sospensione sopracitato, indispensabile all’allucinazione che invade le sinapsi della voce narrante.
Malinconia e orrore, brutalità e immensa tenerezza: tutto è comunque propedeutico alla terza parte di Spettri Diavoli Cristi Noi, la più intensa, la più potente, la più poetica, quella che riscatta la Frida e l’universo personale della Confraternita. Si chiude un cerchio, si sfida il male senza più maschere, si sbugiardano i nascondigli, la visione d’insieme non è più periferica e tutto può ricominciare dopo la follia del fuoco. E la neve tornare a cadere.
Un solo monito, però: Non chiedere mai più al diavolo di occuparsi del diavolo.
Qualunque cosa significhi.
Riccardo Ielmini, anno 1973, vive a Laveno-Mombello ed è Dirigente scolastico. Ha pubblicato i libri di versi Il privilegio della vita (Atelier, 2000) e Una stagione memorabile (Il ponte del sale, 2021). Ha vinto il Premio Chiara Inediti 2011 con la raccolta di racconti Belle speranze (Macchione, 2011). Ha pubblicato il romanzo Storia della mia circoncisione (Unicopli, 2019). Suoi racconti sono usciti su riviste e nell’antologia Splendere ai margini (Oligo, 2023).
In copertina: Edvard Munch, Oscura foresta di abeti

