Di Annachiara Mezzanini
Tutti dormivano, tutto era quiete, e una volta di più rimasi colpita
da quanto fossi lontana da ciò che mi era veramente familiare,
ma non desideravo nulla: mi sentivo completamente smarrita
e questa sensazione ne portò un’altra – una sensazione di felicità.
Jamaica Kincaid
Lettere e passi, a volte, possono condurre verso il medesimo obiettivo, nonostante – a prima vista – essi siano componenti di mondi eterogenei e distanti tra loro. Ma talvolta penna e scarpone si fondono e uniscono, in un susseguirsi di tonfi sulla terra e di increspature della carta che riconducono ad un viaggio, al tempo stesso reale e astratto. La meta indistinta di tale percorso, che dal basso del nostro personale punto di partenza ci ricorda una vetta irraggiungibile, avvolta da accumuli di nuvole dense, si fa spazio tra i desideri inespressi e la quotidianità anestetizzante, riuscendo a prendere forma e sostanza soltanto in alcuni eccezionali casi. È questa l’esperienza fisico-letteraria di Jamaica Kincaid, la quale, attraverso parole e sentieri, ci conduce nel suo rigoglioso e amato giardino nel Vermont, passando per l’Himalaya. La deviazione potrebbe sembrare insolita, ma terminati i capitoli del suo diario di viaggio, si palesa come tappa fondamentale; locus amoenus entro cui poter osservare noi stessi e la vegetazione incolta, prototipo del giardino privato fatto di fiori odorosi e lessici familiari.

Alle pendici del nuovo millennio, nel cuore di un autunno acerbo, connotato dal sapore metallico e avvolgente del primo anniversario di uno degli attentati più discussi e sentiti in America come in tutto l’Occidente, con il quale hanno inizio gli anni Duemila, Kincaid decide di prendere parte ad una spedizione sull’Himalaya, con l’obiettivo di raccogliere i semi delle piante che abitano indisturbate quei luoghi. Lei ci restituisce quel viaggio in prosa, Passeggiata sull’Himalaya, una prosa che Adelphi riporta in libreria con una traduzione curata da Franca Cavagnoli.
Accompagnata da un’equipe di amici, uniti in sorte dalla stessa fitofilia, un orticoltore americano e due coniugi botanici del Galles, Kincaid segue il flusso dei preparativi per quel lungo viaggio, raccogliendo consigli prima ancora che semi, in vista dell’esplorazione nel Nepal Orientale. In un susseguirsi ritmato di prime volte – partenze e ritorni, salite e discese, alte temperature e incontrollabili temporali, letture necessarie e sanguisughe moleste – il gruppo di abili conoscitori e raccoglitori di piante si cala nelle foreste e tra le gole rocciose ai confini con il Tibet, in una terra contemporaneamente arsa dal sole e mangiata dalla neve. Il letto scosceso che ospiterà le loro membra stanche a fine giornata, darà luogo a sogni disturbati, ma anche ad avventure meravigliose, che solcheranno per sempre, parimenti, le loro esistenze e le loro serre.
Il bottino raccolto nei giorni trascorsi in precario equilibrio tra i fiumi Arun e Barun, impressi nelle parole e nelle scarpe dell’autrice-protagonista, conduce il lettore in una duplice interpretazione della storia stessa. Essa, infatti, può essere vista e percepita come una ricerca spasmodica di un piccolo gruppo di innamorati, subito anticipati dagli sherpa e dalla guida locale, che irrazionalmente agli occhi dei profani in materia, setacciano reconditi lembi di mondo, con l’unico bizzarro scopo di trovare, sotto foglie variegate, piccoli semi maturi da poter ripiantare nei loro cari giardini domestici. Per altri, invece, il percorso di Jamaica, Dan, Bleddyn e Sue altro non è che un mistico sentiero. La metafora del raggiungimento della vetta, ormai abusata dalla piccola e grande letteratura, viene qui interpretata alla lettera. Kincaid e compagni varcano realmente i confini delle immense montagne nepalesi, raccolgono concretamente con estremo entusiasmo i semi di piante note e meno note e le pagine che compongono Passeggiata sull’Himalaya ne sono il tangibile resoconto.
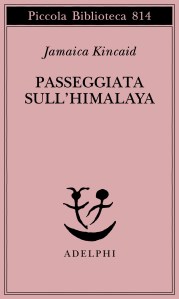
Come ogni storia di avventura anche la passeggiata di Kincaid accoglierà i propri antagonisti, intenti nell’ostacolare la grande abbuffata di semi. Essi saranno semplici intoppi di percorso, come la “prevedibile imprevedibilità del tempo” o la scarsità di piante pronte a donare i propri segreti, o imprevisti più aspri, come la presenza dei maoisti, palesata dal sole rosso impresso sui ponti e sulle case, lasciato di passaggio sulla via.
Attraverso una routine cadenzata da gesti semplici, ma tutti connotati da un preciso scopo esistenziale, veniamo guidati nell’arco delle giornate di scoperta, tra le colazioni preparate nel campo, le scalate e le discese delle ricerche, gli scorci mozzafiato e il ritorno, la sera, nelle tende allestite dai portatori dei bagagli ed entro le quali libri e chiacchiere accompagnano il sonno. La peculiarità aggiuntiva di questo peregrinare sta proprio in quest’ultima fase che scandisce il tempo, ovvero nella presenza costante dei libri, che cullano e indirizzano il passo successivo. Kincaid, infatti, prende con sé un ulteriore compagno, il quale nutrirà in lei un senso di familiarità con i luoghi e le genti fuori e dentro la pagina. Si fa riferimento a Frank Smythe e al suo testo sulla fallimentare spedizione sul monte Kangchenjunga del 1930, personale fonte di ispirazione per Kincaid.
La fine di questo viaggio, che esso sia limitato dal numero di parole con cui l’autrice lo racconta o
dal reale conteggio dei giorni che hanno separato l’attimo della partenza dal punto di ritorno, viene misurata essenzialmente da bellezza e consapevolezza. La prima, risiede in quello che, oggi, è il passato, il tempo dentro il quale si è svolta la ricerca; la seconda, è propria dello spirito che ne è conseguito, è l’accettazione che non ci sarà mai alcun giardino terreno, per sua natura artificiale e costruito, che non custodisca al suo interno la vita di un qualcosa nato altrove. Il nostro familiare è stato, in un momento precedente, a noi estraneo.

