Di Giulia Oglialoro
«Il lavoro interiore è attivismo». Basterebbe questa frase a illuminare l’originalità de La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa di Giusi Palomba, edito da Minimum Fax. A oltre un anno dalla pubblicazione, questo agile e ricchissimo saggio, che intreccia letteratura, cinema, pratica femminista e scienze sociali, non smette di generare dibattiti, incontri, profonde riflessioni sulla violenza di genere e sui modi più e meno efficaci che adottiamo per contrastarla. Tutto comincia quando l’autrice, trasferitasi a Barcellona, prende parte a un processo di “giustizia trasformativa”: Bernat, suo amico fidato, nonché una delle anime del collettivo di cui la stessa Palomba fa parte, viene accusato di violenza sessuale, ma la vittima, di nome Mar, non intende seguire l’iter classico e sporgere denuncia, sottraendosi così una sfiancante e dolorosa «ricostruzione dei fatti», in cui ogni suo comportamento e abitudine verrebbe probabilmente passato al setaccio dalle autorità. Ciò che chiede Mar è, invece, un’azione collettiva che coinvolga tutti i membri della comunità, grazie al quale Bernat possa davvero «comprendere l’impatto della sua violenza e cercare di ripararla».
Niente repressione, marginalizzazione e, soprattutto, niente carcere – un mero luogo in cui «si riflette esattamente la società machista di fuori, le stesse strutture sociali violente». Quella sognata e raccontata da Palomba è una giustizia «senza punizioni, ma d’altra parte senza nemmeno ricompense immediate», dove non esiste sentenza ma solo una lenta e difficile presa di responsabilità collettiva, dove ognuno riflette sulle azioni che, consapevolmente o meno, assecondano comportamenti abusivi e dinamiche di potere. Una giustizia fitta e complessa come trama che continua a ben oltre le pagine del libro, perché, dice Palomba, «non c’è fine in un processo trasformativo, è forse questa la cosa più difficile da accettare».
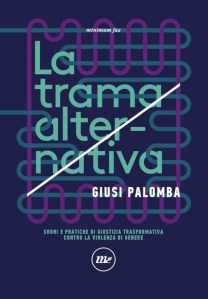
La trama alternativa è un titolo più che mai calzante, perché alternativa è innanzitutto la scrittura con cui affronti il tema della violenza di genere. Se la prima parte del libro è un racconto in prima persona, in cui descrivi la tua partecipazione agli incontri di Barcellona, nella seconda parte rifletti più ampiamente sui concetti di giustizia e violenza. Hai avuto modelli in fase di scrittura, e, soprattutto, da dove nasce l’esigenza di tenere insieme i due piani, quello personale e quello saggistico?
Non posso parlare di esigenza, più che una scelta è stata una resa obbligata, in tutti i sensi. All’inizio ho cercato di fondere le due parti, ma non c’era modo, e la mia editor Alice Spano mi ha come autorizzata a seguire quello che stava uscendo fuori. Ora, tutto questo ha avuto effetti interessanti: c’è chi si lega maggiormente alla parte saggistica, chi a quella più esperienziale, e chi consulta i capitoli in disordine. Oltre ai miei modelli, sicuramente ha influito la maniera di entrare nelle cose, se vogliamo multimediale. Mi interessa molto superare l’idea di scissione tra cultura alta e cultura bassa, come se solo i libri fossero degni di entrare tra i riferimenti di un testo; quindi, ci sono spunti di diversi tipi che ho un po’ costretto alla coesistenza.
Il processo di giustizia trasformativa è tanto affascinante quanto complesso, e nel libro ti soffermi molto sulla quantità incredibile di tempo, energie e preparazione che richiede. Per quanto sia del tutto insufficiente approcciarsi alla violenza invocando il carcere duro, più polizia o punizioni esemplari, la giustizia trasformativa è pensabile al di fuori di piccole e solide comunità?
La cosa più importante da dire è che il mio lavoro non è decidere dove la giustizia trasformativa sia più o meno pensabile. Questo spetta alle comunità stesse, facendo accurate considerazioni, dal livello organizzativo e politico, alle risorse emotive e materiali a disposizione e alla disponibilità dei membri a impegnarsi in questo percorso che è lungo e faticoso e tocca tasti molto dolenti. La storia raccontata serve a esporre una possibilità e a dare testimonianza di gruppi che l’hanno già esplorata. E pensare l’impensabile è sempre più facile quando c’è chi l’ha fatto prima di noi, serve per affrontare il futuro nella maniera più generativa possibile e a tenere la mente aperta, aldilà della possibilità di attivare un percorso specifico.
Una delle parti più acute e originali del libro è a mio avviso quella in cui ti concentri sul mostro così come raccontato dai media, di solito «un marginale, un uomo senza potere, né prestigio (…) un singolo portatore di ultraviolenza dall’origine misteriosa», che ha nel serial killer la massima incarnazione. Ho trovato illuminante il passaggio in cui, citando lo studioso Eric Cullen, ricordi che «due terzi dei serial killer della storia siano statunitensi», e cioè provengono da un paese ultra-capitalista, in cui marginalizzazione e solitudine sono connaturate e diffuse. La deformazione di cui dovremmo occuparci non risiede tanto nell’animo dell’individuo, quanto nella società?
Da quando vivo in Gran Bretagna, sono scioccata dalla enorme quantità di notizie di persone che vivono e muoiono in casa in completa solitudine. Nel 2016, per gestire la questione, nacque addirittura il cosiddetto Ministro della Solitudine, una commissione nata per supportare organizzazioni sociali e programmi dedicati al problema. Tristemente, l’ideatrice della commissione, Jo Cox, deputata Labour, fu ammazzata nel 2016 da un uomo che poco prima di pugnalarla urlò “Britain First”. Oggi l’uomo di nome Thomas Mair sta scontando un ergastolo. Questo è uno dei numerosi esempi di un evento tragico raccontato e ricordato come la follia di un singolo che, tra l’altro, quasi nessuno più si ricorda, dato che si tratta di suprematismo bianco.
Eppure, quella terribile violenza si consumò una settimana prima del referendum per la Brexit, in un clima di odio sociale a livelli intollerabili. Il governo conservatore stava favorendo un clima di paranoia, un ambiente ostile alla convivenza, a cui di sicuro le persone più instabili psicologicamente o più schierate a destra erano parecchio sensibili. Possiamo davvero dire che la tragica morte di Jo Cox sia stata soltanto responsabilità di un singolo? Le reti di solidarietà vengono smantellate o sono continuamente sotto attacco, le occasioni di incontro tra le persone si sono ridotte drasticamente e quella sorveglianza reciproca che è una forma di cura tende a essere sostituita dalla corsa alla carriera di successo, dall’individualismo sfrenato, o nelle zone più svantaggiate dalle più svariate forme di sofferenza e degrado. Le conseguenze rimangono fuori dai radar finché non sono più arginabili, e la società così come l’abbiamo organizzata non è che sappia risolvere il problema, ma interviene soltanto nel punto finale del percorso a punire e rinchiudere. Di questa storia salta agli occhi qualcos’altro: Thomas Mair, l’uomo che ha ucciso Jo Cox era descritto come un “loner”, un uomo disoccupato e con una sofferenza psichica, che probabilmente avrebbe votato per l’estrema destra. Una delle persone che la sua stessa vittima cercava di aiutare.
Gli incontri a cui hai partecipato a Barcellona sono stati voluti dalla stessa donna che aveva subito violenza. Mi pare che tutti i processi di giustizia trasformativa citati nel libro siano stati immaginati da donne. Che gli uomini partecipino è fondamentale, ma spesso oppongono resistenza, perché «non vogliono sentirsi dire che sono i principali fautori di violenza». Come si esce da questa contraddizione?
Credo che difficilmente un soggetto attore di un’oppressione sia portato a cambiare direzione senza una collettività che eserciti una pressione. E soprattutto, la realtà non è mai così lineare, oppressore e oppresso non sono identità monolitiche, ci sono tante intersezioni di cui tenere conto. Se parliamo in generale, gli uomini che agiscono violenza sono il prodotto di una cultura, se non cambia la cultura non potranno mai cambiare i singoli uomini. La buona notizia è che se non concentriamo tutta la responsabilità in un punto, ogni individuo è potenziale portatore di cambiamento. Come del singolo violento, d’altra parte, sono critica anche davanti alla narrazione del singolo consapevole. Non dico che non sia possibile comprendere da soli certe cose, ma che in questi casi la motivazione è più spesso l’autocompiacimento, il benessere personale più che il senso di giustizia sociale.
Citando Ursula K. Le Guin, dici di voler essere «realista di una realtà più grande». Insieme a bell hooks, la maestra della fantascienza sembra essere un altro dei tuoi riferimenti più nitidi. Che ruolo può avere secondo te la letteratura nell’immaginare una società diversa?
Sicuramente ci sono momenti in cui la letteratura non arriva, ad esempio quello dell’azione. Ma l’azione ha bisogno di immaginari nuovi, specie in questi tempi oscuri e la responsabilità che sento più forte è quella di creare spazi, aprire o allargare momenti di creazione e di immaginazione o riconoscere dove stanno mancando. Le persone che fanno attivismo sono fagocitate dalla agenda militante e spesso non riescono a concederseli questi momenti, piuttosto finiscono a percorrere solchi conosciuti, per mancanza di tempo e spesso di energie e perché obiettivamente le oppressioni che ci ritroviamo a contrastare sono potenti e lavoriamo molto in difesa. Il ruolo della letteratura allora può essere non soltanto creare quello spazio prima dell’azione, per pensarla, migliorarla, ma riportare la dimensione del sogno dove sta mancando.
In copertina: artwork by Gérard DuBois

