So soltanto che quelle terre
per quei confini che ti mostrai
se le contesero per anni.
Questo tesoro volevo darti.
Giulia Martini, Tresor
La poesia sancisce la realtà. Il gesto poetico – concepito anche come un dire – muove le cose e diventa strumento per ripensare la relazione col mondo e con gli altri. In Tresor, di recente pubblicato per Interno Poesia, Giulia Martini prova a farlo attraverso un’operazione linguistica sofisticata e attenta che fonde insieme l’italiano antico – tratto dai documenti dei volgari italiani ma anche dalla poesia ottocentesca e novecentesca – con quello contemporaneo, e ritesse la trama di un amore che trova nella rottura definitiva la sua salvifica composizione.
In questo, probabilmente, consiste il tesoro: nel recupero insperato di un noi nel quale il sé si sciolga e si ritrovi. Di questo noi il lettore è chiamato a far parte aggiungendo significato ai versi ed espandendo il perimetro dell’immaginabile e, per ciò stesso, del possibile. Mentre il poeta, sempre in ascolto di una voce, ha, ancora prima, il ruolo di raccoglierla e di trascriverla per renderla finalmente materia umana. Nella pagina, dunque, resta impressa la traccia del cortocircuito tra ricezione e produzione poetica che unisce chi scrive e chi legge in un passaggio di stato che non ha soluzione di continuità: un attraversamento del linguaggio che è anche un attraversamento di accadimenti e stati d’animo dei quali ciascuno cerca di trovare la radice e la giustificazione. Non solo chi percorre il libro, allora, ma anche il poeta si affida al potere del testo e scopre ciò che dice pian piano, a ogni successivo ascolto e a ogni rilettura, nella perdurante autenticità che viene dalla parola.
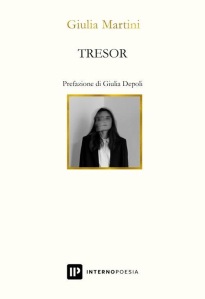
Tresor recupera la tradizione degli antichi documenti dei volgari italiani e attinge alla lingua come punto d’avvio per affrontare la questione dell’origine. Ma fa anche di più: nell’assemblare l’italiano antico con quello contemporaneo compie un attraversamento, un inire che è un vero e proprio entrare dentro, passare da uno stato all’altro. È così?
È così.
Attraverso l’operazione linguistica di Tresor, l’io poetico si spezzetta e si moltiplica in quella che definirei una “individualità aumentata”. Era questa la tua intenzione?
Allora, non parlerei di «intenzione» nella misura in cui per me la poesia non dipende mai da una progettualità che ne sta a monte o ne viene prima. Anzi, vale il contrario: sono io che scopro quello che il testo mi dice, spesso capendolo solo molto tempo dopo. Più che spezzettarsi, mi sembra che questo io si sciolga e si ritrovi in una soggettività espansa a tutti i suoi possibili interlocutori: a questo proposito, uno dei componimenti dice: «Non c’è nessuna differenza fra me e voi, / […] avremo abbassati gli scudi a uno». E forse il tesoro da conquistare alla fine ha a che fare proprio con questo «noi». C’è un verso – tecnicamente non sarebbe un verso, ma mi si passi il termine – molto bello di Alessandro Broggi che dice «soltanto il senso del noi ci fa stare un po’ meglio»: ecco, più che «individualità aumentata» e «soggettività espansa» tirerei in ballo proprio questo «senso del noi».
All’interno della raccolta, tu parli come in veste di notaio, il quale, per natura, nel mettere per iscritto, allo stesso tempo regolamenta le cose della vita quotidiana. La poesia può avere la natura pratica di un atto notarile? E in che termini?
La poesia ha senza dubbio la natura pratica di un atto notarile. È antica la concezione della parola poetica come una parola demiurgica, immediatamente pragmatica, ovvero una parola che crea la sua stessa realtà, non meno reale di quella cui ci si riferisce quando maldestramente parliamo di «realtà». Penso al gesto poetico come a un evento, qualcosa che accade – quando accade, certo – accadimento che corrisponde necessariamente a un sommovimento di uno stato di cose. Se questo sommovimento non c’è, la poesia non mi interessa. Ma se questo sommovimento c’è, allora non c’è differenza fra la poesia e le antiche formule del diritto, per cui sbagliare una parola comportava perdere la causa, con tutte le conseguenze materiali in questa implicate.
Nella tua poesia c’è una doppia musica: quella del testo scritto e quella della lettura ad alta voce – che tu fai magistralmente – quasi a fornire più chiavi di lettura degli stessi versi…
Ti ringrazio, Annachiara. Prima dicevo che la poesia è un evento; qui ti aggiungo che è un evento orale, che avviene, cioè, all’interno del sistema ricezione-emissione. Mi corrisponde perfettamente, in questo senso, il motivo archetipico del dictatum, per cui una voce detta – che si chiami Amore, Musa, Ispirazione o Dio credo sia abbastanza indifferente – e il poeta nota, cioè è qualcuno che riceve e trascrive, di nuovo, proprio come il notaio. Questa è solo la prima fase dell’evento, che si compie in una nuova ‘dicitura’ ad alta voce (quello che oggi si chiama reading, anche se ci tengo a precisare che io non leggo, ma dico, perché so i testi a memoria) e in un nuovo ascolto (che stavolta non è l’ascolto del poeta ma l’ascolto del pubblico). Si può dire che la poesia vive in questo cortocircuito ricezione-produzione, dove la ricezione viene prima e da ‘fuori’. In sostanza è questa la ragione per cui penso al libro come a un mero supporto cartaceo, mutilato rispetto all’esperienza in presa diretta. La doppia musica che tu individui credo dipenda dal fatto che i versi di Tresor sono quantitativamente scanditi, ogni sillaba ha, cioè, una precisa durata in termini temporali: la dicitura ad alta voce restituisce questo aspetto, che invece la pagina di carta tace, proponendo una musicalità, appunto, diversa.
“Tesoro”, “tresor”, “tresoro”, “tresoiro” sono le numerose declinazioni della stessa parola che si trovano disseminate nelle pagine. Quanti significati si possono immaginare per ciascuna di esse e quanto, invece, delle ragioni di questo lavoro è racchiuso nella parola originaria che dà il titolo al libro?
Quanti significati vuoi: come scrive Giulia Depoli nella prefazione, la ricerca del tesoro «potrà chiudersi solo con l’apporto di tutti i lettori possibili»: credo che intendesse associare l’atto ermeneutico, che ogni lettore inevitabilmente compie, a quella soggettività espansa che si diceva ed è per questo che alla prima domanda ti ho risposto «È così» senza argomentare ulteriormente. C’è poi anche la questione della lingua: se ci pensi, non si parla del volgare italiano, ma dei volgari italiani; di fatto l’italiano non esiste, è un concetto astratto che non prende vita se non nelle singole esecuzioni dei singoli parlanti, nei singoli contesti in cui sono agganciati. Nel titolo tutto questo è enciclopedicamente compreso: Tresor, infatti, è il titolo della prima enciclopedia in lingua volgare, scritta dal notaio Brunetto Latini in esilio. Ma soprattutto, Tresor non è un titolo mio.
Intervista a cura di Annachiara Atzei
In copertina: artwork by Leonora Kerrington

