Di Annachiara Mezzanini
Attraverso i tuoi occhi, vedrò il cuore più interno e chiaro di un cavolo bianco, che nasconde le foglioline più preziose. Vedrò la freddezza di una falce di luna in pieno giorno. Prima o poi, vedrò un ghiacciaio. Contemplerò i riflessi azzurrini su ogni sfaccettatura di quell’enorme massa di ghiaccio che non è mai stata viva e che, forse per questo, sentiamo ancora più sacra. Poi, nel silenzio di un bosco di betulle, vedrò te. Ti vedrò nella quiete di una finestra da cui entra il sole invernale. Nel pulviscolo luminoso che danza lungo i raggi di sole obliqui che battono sul soffitto. E in quel bianco, tra tutte quelle cose bianche, respirerò il tuo ultimo respiro.
Tutto il bianco, Han Kang
Il teatro si riempie lentamente, complici i movimenti ovattati dai cappotti, che strisciano l’uno contro l’altro nel budello di passaggi e scalini che portano le gambe verso il posto libero più vicino. Il vapore del corpo umano, sbalzato dal freddo esterno al tepore della stanza, si solleva impercettibilmente dalle teste degli astanti, tutti intenti a non pestarsi i piedi e a guardarsi attorno con un sorriso lieve, di circostanza. Metti caso che si inciampi nello sguardo di qualcuno, almeno sul volto la cortesia è già pronta, visibile in quella increspatura.
Da casa, a distanza, l’attesa è un monitor bianco. Nessun rumore, nessuna voce. Solo un’immagine di profilo e la copertina in primo piano.
Qualche minuto dopo, si spengono le luci, cala il chiacchiericcio e dal palco emergono le figure che cominciano a raccontare, con lingue e toni differenti, cosa celano quelle pagine nuove, odorose di carta. Il nero prende il posto del bianco sullo schermo. Un non colore che scaccia un altro non colore.
Secondo il vocabolario Treccani, nel linguaggio scientifico il colore bianco si definisce come la sensazione visiva prodotta dalla luce solare, la cui caratteristica è quella di contenere tutti i colori fusi insieme. Il bianco, quindi, non è un colore o, per meglio dire, è un colore acromatico, che non presenta una tinta. Per Han Kang, invece, il bianco è una lista di cose. Tenda di merletto, zollette di zucchero, lampadina a incandescenza, la quiete. Ma il bianco, come ci insegna l’autrice stessa, nella sua lingua madre è sia colore visibile a candido (hayan) sia idea pura e ciclica, concetto profondo di vita, morte e ritorno (huín).
Il libro bianco, pubblicato in Italia da Adelphi lo scorso novembre e tradotto da Lia Iovenitti, parte da questi oggetti, da queste memorie, e si allunga nel tempo, prendendo una forma frammentaria e densa. Ogni pagina è un ricordo connesso al colore, legato al passato della scrittrice e al suo viaggio a Varsavia. Ogni riferimento a sé stessa è anche ponte verso la propria madre partoriente, verso quella creatura appena nata e già morta che fu sua sorella.
Il bianco è lutto e nostalgia, ricordo e oggetto, viaggio di scoperta e ritorno a casa. L’esperienza che sta alla base di tutto questo.
Il tempo, in questa lista bianca che ricorda una raccolta poetica, si è dilazionato. Siamo nell’autunno del 1966 e, contemporaneamente, nell’autunno del 2014. Siamo nell’estate del 2013 e nella primavera del 2018. Ogni data, un fatto e, a ogni fatto, il suo corrispettivo ricordo bianco. C’è un io, una lei, un insieme multiforme di bianco. C’è la Corea, l’Europa e la neve bianca che ricopre le strade e i palazzi distrutti dalle bombe. La tragedia vissuta dal popolo di Han Kang riverbera sui vetri opachi di freddo delle case nuove di Varsavia; lo sguardo è il medesimo, il passato si assomiglia, il futuro – anche qui – è totalmente incerto e bianco, huín.
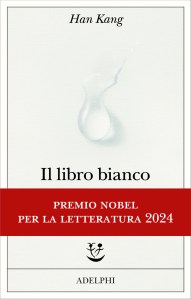
La consapevolezza viene camminando, epifania istantanea che si palesa quando meno te lo aspetti. Han Kang passeggia lungo il fiume e si ricorda. Pensa alla madre ventiduenne che partorisce sola nella sua casa di campagna, isolata. Pensa alla creatura vissuta appena un paio d’ore e, improvvisamente, sente le parole udite per tutto il tempo da sua sorella: non morire. In una vita durata appena centoventi minuti, le uniche vibrazioni percepite sono state quelle emanate dalle corde vocali della madre che, atterrita, supplicava la figlia. Quella stessa voce, mutata nel tempo, aveva riempito le orecchie di Han Kang durante la stesura del suo celebre libro Atti umani (Adelphi, 2014), all’interno del quale un’altra donna cerca di mantenere la stessa promessa: non morire. Varsavia, sullo sfondo, restituisce luce a questi ricordi, riconnettendoli tra loro. Così come il suo corpo venne interamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e, poi, plasmato nuovamente attraverso gli occhi e le mani di chi lo aveva vissuto, allo stesso modo, Kang restituisce la vita alla sorella, donandole la propria voce e le proprie gambe.
Morte, luce, eterno, ferita. Quante parole sono qui usate come emolliente per cercare di riparare una vita spezzata dal tempo e una dall’emicrania. Il senso più profondo dell’esperienza umana e personale dell’autrice è racchiuso nel bianco di questo libro, nelle parole scelte per ricordare e sopravvivere, in un fragile e viscerale susseguirsi di oggetti vissuti e osservati. Tutto, all’interno di queste pagine, è inevitabilmente e intrinsecamente huín.
In copertina: Gustave Caillebotte, Tetti sotto la neve, 1878

